|
𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐕𝐀 𝐒𝐎𝐓𝐓'𝐀𝐂𝐐𝐔𝐀. 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐑𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐈 "𝐌𝐔𝐑𝐀𝐆𝐋𝐈𝐎𝐍𝐈" Di 𝙄𝙧𝙚𝙣𝙚 𝙎𝙖𝙡𝙫𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞 Il Tevere è stato da sempre la ricchezza e uno dei tormenti di Roma. Periodicamente, il fiume straripava allagando le zone più basse della città, in particolare il Campo Marzio, la valle del Circo Massimo (Vallis Murcia) e quella del Foro Romano (Velabro), le più vicine al corso d’acqua. Secondo Rodolfo Lanciani le inondazioni sono state 132. Ogni straripamento lasciava dietro di sè morti e crolli di edifici e quando le acque si ritiravano, lasciando fango e melma stagnanti, erano causa di numerose epidemie. Passeggiando per il centro storico, di frequente ci si imbatte nelle epigrafi che ricordano le inondazioni e l’altezza raggiunta dalle acque in piena in quel punto. La memoria più antica è al Rione Ponte, dove una lapide all’Arco dei Banchi ci ricorda l’alluvione del 5 novembre 1277: “𝐻𝑢𝑐 𝑇𝑦𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑢𝑠 ℎ𝑖𝑛𝑐 𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 𝐴𝑛𝑛𝑜 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑀𝐶𝐶𝐿𝑋𝑋𝑉𝐼𝐼 𝐼𝑛𝑑 𝑉𝐼. 𝑀. 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏. 𝑑𝑖𝑒 𝑉𝐼𝐼. 𝐸𝑐𝑐𝑙 𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒". "Qui arrivò il Tevere, ma torbido; di qui presto si ritirò nell'anno del Signore 1277, sesta indizione, settimo giorno del mese di Novembre; mentre la chiesa era vacante." E ancora, nei pressi della chiesa di S. Eustachio, su un’altra targa si legge: "𝑁𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑛𝑛𝑜 1495 𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒, 𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑜, 𝑐𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑎𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 - 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑉𝐼 𝑃𝑎𝑝𝑎 - 𝐴𝑛𝑛𝑜 𝐼𝐼𝐼". Dopo l’inondazione, terribile (di 17,22 metri) e dalle conseguenze disastrose, del 28 dicembre 1870, lo Stato italiano decise la costruzione degli argini di travertino, o “Muraglioni”, che se pur risolsero uno dei problemi da cui da secoli era afflitta la città, d’altro canto ruppero quel legame indissolubile che legava, da migliaia di anni, Roma al suo fiume. La costruzione degli argini terminò nel 1926. Le distruzioni furono particolarmente gravose nel 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙍𝙞𝙥𝙖 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚, sulla riva destra del Tevere, e nel 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙍𝙞𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖 , risistemato, precedentemente, da Alessandro Specchi con grandi scalinate semicircolari e una fontana a scogliera. Qui esisteva la splendida Villa Altoviti, con affreschi di Giorgio Vasari e ricca di reperti archeologici. Il suo abbattimento risale al 1889, al momento in cui il nuovo quartiere di Prati fu dotato degli imponenti muraglioni oggi visibili. Di seguito le foto delle due targhe, del porto di Ripetta, Villa degli Altoviti e vari immagini di Roma prima degli argini e degli stessi in costruzione. Foto da web 𝗜 𝗤𝗨𝗔𝗧𝗧𝗥𝗢 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗜𝗧𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗔
Di Irene Salvatori Un breve accenno alla pittura romana e ai suoi quattro stili detti, convenzionalmente, "pompeiani". Questo aggettivo deriva dal fatto che la maggioranza delle pitture -e quindi uno studio sulla loro evoluzione- è stata rinvenuta nel celebre sito di Pompei. 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 (150 a.C.-80 a.C. circa) è una pittura esclusivamente decorativa, non ci sono soggetti ma la riproduzione di materiali pregiati come il marmo. 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 (80 a.C.-20 a.C. circa) con effetto di trompe l'œil vengono affrescate vedute di paesaggi inquadrati da portici o finestre; scorci di giardini con piante e animali, scene che rappresentano a tutto campo uomini e donne. Grande attenzione ai particolari che vengono resi con abili prospettive. 𝐓𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 (20 a.C.-50 d.C. circa) la parola d’ordine è semplificazione. Scompaiono le vedute ariose e si divide in maniera gerarchica le pareti; prevale un unico colore di fondo, spesso il rosso o il nero, al centro del quale sono rappresentati dei quadretti, i 𝑝𝑖𝑛𝑎𝑘𝑒𝑠, con figure, finte nicchie, piccoli paesaggi. Molte di queste pitture sono state ritrovate anche nelle residenze di personaggi di ceto medio: siamo agli inizi dell’impero. 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐞 (dal 50 d.C.) detto anche “stile illusionista”, si torna alla pittura di scenari in prospettiva, ma adesso vengono aggiunte le figure umane, mentre gli elementi architettonici, che sembrano delle quinte teatrali, non sono dipinti ma realizzati in rilievo con lo stucco. Di seguito le immagini dei quattro stili Foto da Web𝗕𝗘𝗟𝗟𝗢𝗡𝗔, 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗔 di Irene Salvatori È il 3 giugno del 296 a.C. e il Senato romano decide di votare un tempo nel Campo Marzio a Bellona, la dea della guerra (da bellum), nonchè, a volte, ritenuta la compagna di Marte. Oggi se ne possono vedere pochi e sparuti resti nell'area antistante il noto Teatro di Marcello. Siamo dunque nel III secolo, un momento storico che vede Roma impegnata nella conquista nei territori confinanti. Il tempio si trovava al di fuori delle mura urbane e quindi in "territorio nemico". Di fronte al tempio si svolgeva una cerimonia antica affidata ai 𝒇𝒆𝒕𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔 che, dalla 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒊𝒄𝒂, un pilastro che simboleggiava il confine tra territorio romano e quello nemico, lanciavano una lancia verso i nemici come atto di dichiarazione di guerra. Tale rituale fu compiuto una prima volta nel 280 a.C. e già alla fine della Repubblica era divenuto desueto. Narrano gli storici romani che qui Silla, dopo aver occupato Roma, parlò, con voce pacata ma minacciosa, ai senatori riuniti, mentre poco lontano si udivano le voci dei seguaci di Mario che venivano trucidati. A far tornare in auge il rito fu Augusto che, nel 32 a.C., dichiarò da qui guerra a Cleopatra. Il tempio - lo si evince dalla Forma urbis severiana- aveva 6 colonne di fronte e nove ai lati. Del luogo dove sorgeva la famosa colonna si è perduta la memoria ma sembra possa essere identificato con un'area circolare rinvenuta davanti al tempio. Le foto mostrano i resti del Tempio di Bellona oggi, una ricostruzione ipotetica e gli scavi per l'apertura di via del Mare. foto da web 𝟓 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟏𝟗𝟒𝟒
𝐔𝐠𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐨, 𝐢𝐥 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨. "Gli americani ormai sono a Roma, sfilano e si scattano foto sui carri armati. Roma è in festa. Non per tutti è così però. La mattina, sul presto, esce di casa il giovane studente di 12 anni Ugo Forno. A piazza Vescovio viene a sapere, da alcune persone, che un reparto di guastatori tedeschi sta cercando di far saltare il ponte ferroviario sull’Aniene. Con altri cinque ragazzi, Antonio e Francesco Guidi, Luciano Curzi, Vittorio Seboni e Sandro Fornari, corre sul posto armato di fucile. I giovani partigiani trovano i soldati che stanno piazzando cariche di esplosivo sotto il Ponte Salario. Ne nasce uno scontro a fuoco furibondo. I tedeschi hanno un mortaio e sparano tre colpi. Il primo a cadere è Guidi. Poi vengono feriti gravemente Curzi e Fornari. Ugo viene colpito a morte dal terzo colpo. I gappisti che accorrono sul ponte lo trovano ancora con il fucile in mano e, avvolto in un tricolore, lo portano in una clinica poco distante. È là che verrà riconosciuto dai genitori. Quel giorno il ponte non fu distrutto per l’eroico coraggio di un ragazzino e dei suoi amici, ed è a loro che Rosellini si è ispirato nella scena finale del film «Roma città aperta». Ugo è l’ultima vittima partigiana dei tedeschi in ritirata da Roma. «Giovane studente romano, durante i festeggiamenti per la liberazione della città di Roma, appreso che i tedeschi, battendo in ritirata, stavano per far saltare il ponte ferroviario sull’Aniene, con grande spirito di iniziativa, si mobilitava, unitamente ad altri giovani, e con le armi impediva ai soldati tedeschi di portare a compimento la loro azione. Durante lo scontro a fuoco veniva, tuttavia, colpito perdendo tragicamente la vita. Fulgido esempio di amor patrio ed encomiabile coraggio». Medaglia d’Oro al Valor civile, 16 gennaio 2013 " Da "Roma violata". Ed. Mursia. Irene Salvatori. 𝐔𝐧 𝐛𝐢𝐦𝐛𝐨... 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞
" Il sole era alto nel cielo e la giornata era veramente molto calda. Il bambino si guardava intorno inquieto. Aveva giocato con le sue noci ma ora si era stancato. Aveva deciso di andare a cercare qualche bella lucertola da stanare per divertirsi un po’ quando vide quello che non avrebbe dovuto vedere: una distesa di tegole si asciugavano al sole, aspettando di essere infornate. Si guardò intorno: non c’era nessuno. Si avvicinò a osservarle. Erano quadrate e piuttosto grandi. Su alcune c’era anche una stampigliatura rotonda. Aveva visto altre volte quei timbri, sapeva che indicavano il nome del proprietario della fabbrica o i nomi dei consoli in carica. Cercò di avvicinarsi per vedere meglio ma la luce era abbagliante e il segno troppo piccolo. Fu allora che gli venne la tentazione di farlo. Era già stato rimproverato per una cosa del genere e gli avevano detto di non farlo mai più. Ma in giro non c’era nessuno e immaginando che l’argilla fosse ancora fresca nonostante il sole, pregustò il piacere di far affondare il piede in quell’impasto umido, morbido e resistente allo stesso tempo. Scelse con cura quella che gli sembrava la tegola riuscita meglio e si avvicinò. Appoggiò piano il piede e poi premette, facendo forza con la punta del piede. Sotto un primo contatto caldo, l’argilla era effettivamente umida come l’aveva immaginata. Lasciò il piede per qualche istante perché la forma rimanesse bene impressa, poi lo alzò per guardare il risultato. Perfetto. Ridendo sotto i baffi sgattaiolò via in punta di piedi. Immaginava la faccia che avrebbero fatto quando avrebbero scoperto quella tegola. L’avrebbero usata? L’avrebbero buttata via? Avrebbero fatto finta di niente? Quello che davvero non poteva immaginare era che la prova della sua disubbidienza sarebbe rimasta impressa per sempre e che, 1897 anni dopo, sarebbe stata ancora sotto gli occhi di tutti" Fonte: Museo Nazionale Romano ©Archivio Fotografico MNR Bollo con i nomi dei consoli Petino e Aproniano, 123 d.C. Dalla via Appia 𝐒𝐔𝐋𝐏𝐈𝐂𝐈𝐎, 𝐈𝐋 𝐁𝐀𝐌𝐁𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐈𝐆𝐈𝐎
di 𝙄𝙧𝙚𝙣𝙚 𝙎𝙖𝙡𝙫𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞 Chiunque passeggi nelle vicinanze di piazza Fiume, a Roma, si imbatte in un monumento funebre, addossato alle Mura Aureliane, che dà mostra di sè con pacata discrezione. Il sepolcro appartiene a un fanciullo di 2000 anni fa, Quinto Sulpicio Massimo, e oggi si trova all’incrocio tra via Piave e la via che porta il nome del ragazzino della tomba, appunto via Sulpicio Massimo. Il rinvenimento fu fortuito: nel corso del cannoneggiamento delle mura del 1870, Porta Salaria fu rovinosamente danneggiata a tal punto che, nel 1871, si venne alla decisione di abbattere la porta rinvenendo, inglobato nelle fondamenta della torre ad est della stessa, il monumento funebre di 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗦𝘂𝗹𝗽𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼. Quello che oggi ammiriamo è solo una copia, l’originale è stato portato anni fa alla Centrale Montemartini. Accanto al monumento, si rinvenne anche un altro sepolcro a camera di epoca sillana, il cui proprietario è rimasto ignoto. Ma chi era Sulpicio? Un bambino prodigio scomparso prematuramente. Lo sappiamo, ci sono dolori che trascendono il tempo e lo spazio. I genitori di Quinto Sulpicio Massimo, addolorati ma orgogliosi, vollero rendere omaggio al figlio, morto a 11 anni, ma già famoso per aver partecipato, appena decenne, al terzo 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛 capitolino (una gara di poesia di alto profilo). Lui, un bambino, in mezzo ad altri 52 poeti (e tra questi anche il noto poeta Stazio), nel 94 d.C. si esibì nello Stadio di Domiziano, davanti a migliaia di persone. Il suo componimento non vinse, ma ottenne una corona, una sorta di premio della critica, come apprezzamento da parte dei giudici, stupiti nel vedere tanta competenza in un ragazzo così giovane. La folla, al pari dei giudici, acclamò questo giovane talentuoso agitando palme e intonando cori. Il monumento funebre di Sulpicio è interamente ricoperto dal testo in greco, come era previsto dalla gara, e in latino, del componimento presentato al 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛 . In questo tipo di gare, a ogni concorrente veniva affidato un soggetto poetico estratto a sorte sul quale, là su due piedi, l’aspirante “novello Virgilio” doveva improvvisare un componimento. Al giovane Sulpicio, leggiamo sul monumento, venne assegnato il mito di Fetonte. In pratica la ramanzina di Giove ad Apollo, accusato di essere stato troppo indulgente con il figlio Fetonte. Dopo la gloria, l’abisso. La fine del ragazzino fu tragica e inaspettata. Alla fine dell’estate del 94 d.C. il fanciullo, per il troppo studio si ammalò e morì, lasciando ai genitori la dolorosa consapevolezza della sua perdita. "𝐴𝑔𝑙𝑖 𝐷𝑒𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑖. 𝑃𝑒𝑟 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑢𝑙𝑝𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢̀ 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑎, 𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎 𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 11 𝑎𝑛𝑛𝑖 5 𝑚𝑒𝑠𝑖 𝑒 12 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖. 𝐸𝑔𝑙𝑖, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐ℎ𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖, 𝑡𝑟𝑎 52 𝑝𝑜𝑒𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝐺𝑟𝑒𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑣𝑒𝑔𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑒𝑡𝑎̀, 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑜̀ 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒. 𝐼 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑎, 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑖. 𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑢𝑙𝑝𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑢𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑛𝑖𝑎 𝐼𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖”. Monete dal Tevere: una messa a punto
di Franco Guillermo Mazzanti A mia cugina Claudia che per me è sempre stata come una sorella maggiore Questo lavoro intende essere una raccolta e un riordino dei dati raccolti negli studi, sui ritrovamenti monetali del Tevere, pubblicati nei Bollettini di Numismatica dell’Istituto Poligrafico dello Stato. Con un’introduzione ad opera di C. M. Carpano, con il suo articolo: “Il Tevere: archeologia e commercio” (in cui tratterà delle prime opere idrauliche nel Tevere, ove sono più frequenti i ritrovamenti di monete). Seguirà poi un approfondimento sulla circolazione monetaria in età romana lungo il fiume Tevere, le cui tematiche furono affrontate durante una tavola rotonda fra il 21 aprile e il 29 giugno dell’86, con la partecipazione dei seguenti studiosi: Sabatino Moscati, Giovanni Gorini, Hans Markus von Kaenel, Maria Radnoti Alfoldi e Francesco Panvini Rosati. Si proseguirà poi a parlare di alcuni dei più importanti scavi archeologici svoltisi nel fiume, con gli articoli di Susanne Frey Kupper sulle monete greche, di Franz E. Koening sulle monete di Caligola, di Hans Markus von Kaenel sulle monete di Claudio, per poi finire con l’articolo sui ritrovamenti del Testaccio e dell’Alveo del Tevere ad opera di Roberto Meneghini e Lucia Travaini. L’articolo di Carpano, pubblicato nei n. 2-3 BdN dell’84, inizia trattando delle opere idrauliche compiute lungo il Tevere col fine di prevenire le improvvise inondazioni del Fiume e quindi di canalizzare le acque in eccesso verso il mare, come ad esempio le cloache che si aprivano lungo le rive del fiume. Importanti autori antichi come Plutarco e Dione Cassio testimoniano che il Tevere aveva da sempre costituito un’importantissima via economica che favoriva i commerci fra nord e sud, fra Lazio ed Etruria meridionale. Vitale per il commercio, poteva però essere un disastro per l’agricoltura a causa delle frequenti inondazioni, le prime opere di canalizzazione a cielo aperto iniziarono sotto il regno di Tarquinio Prisco, al V secolo risalirebbe la cloaca in cappellaccio ritrovata nel Foro ma i primi interventi documentati sono databili ad un periodo compreso fra il III e II sec. a.C. All’ultimo periodo repubblicano risalirebbero le cloache ritrovate presso il Circo Massimo e il Colosseo; vicino S. Maria in Cosmedin, che ora ospita la celeberrima Bocca della Verità, si trova l’attuale sbocco della Cloaca Maxima, costruita in blocchi radianti tra il 120-80 a.C. Passando ora a parlare dei porti l’autore ci informa, in base ai ritrovamenti archeologici, che il primo porto di Roma era localizzato nei pressi di S. Maria in Cosmedin ed era chiamato Portus Tiberinus. Oltre al Portus Tiberinus vi era anche il Navalia (porto militare di Roma di cui ancora non si conosce bene l’ubicazione) e il porto situato in località Tor di Nona. Alcuni ipotizzano che il Navalia si trovasse nell’area del Campo Marzio altri che si trovasse fra il Foro Boario e l’Aventino. Al II sec. a.C. risalgono le prime sistemazioni degli argini del fiume con ormeggi in opera quadrata in tufo, in coincidenza con l’aumentata importanza politica di Roma nel Mediterraneo con la fine della seconda guerra punica, e proseguirono fino alla seconda metà del I secolo a.C. con un periodo di maggior attività fra il 193 e il 174 a.C. Nei pressi della Basilica di San Paolo sono stati ritrovati, nel corso della storia, numerosi blocchi di travertino grezzo a testimonianza del fatto che lì doveva trovarsi un altro porto per lo scarico delle merci. Sempre in epoca imperiale venne costruito uno dei porti fluviali più importanti della città, il Porto del Testaccio, vicino agli empori e agli Horrea omonimi. Proprio vicino al porto prese forma, nel corso della storia il Mons Testaceum, che non è altro che un accumulo di anfore usate che, una volta esaurita la loro impermeabilità, venivano li gettate e sotterrate. Di epoca traianea, questo porto metteva in contatto le regioni più interne dell’Etruria e dell’Umbria con lo scalo commerciale di Ostia Antica in cui le merci, provenienti da tutto il Mediterraneo, venivano imbarcate sui battelli fluviali trainati a riva da animali. E proprio Ostia si trovava il più importante scalo commerciale di Roma, la Porta dell’Urbe sul Mediterraneo, fatto costruire da Claudio e ampliato da Traiano esso appariva anche sulle monete imperiali per esaltare la gloria degli imperatori. Il primo progetto, terminato poi da Nerone, prevedeva la costruzione di due moli aggettanti, con un’isola artificiale in mezzo, sulla quale si trovava un faro, questo nuovo porto venne rinominato Portus Augustis Ostiensis. A causa delle precarie condizioni del fondale del Tirreno, sul quale il porto Claudiano tendeva ad inabissarsi, Traiano fece costruire un altro porto esagonale, di ben 32 ettari, collegato sia al porto di Claudio che al Tevere, con darsene e magazzini in grado di costituire un rifugio sicuro per le imbarcazioni. Il porto prese il nome di Portus Traiani e fu utilizzato ininterrottamente per tutta la successiva età imperiale “Si calcola che ogni anno giungevano a Roma fino a circa 12.000 navi da tutto il Mediterraneo per un totale approssimativo di circa 800.000 tonnellate di merci, tenendo in conto eventuali problematiche relative al clima o all’assetto geopolitico del Mediterraneo”[1]. Presumibilmente il Tevere era navigabile in primavera e autunno mentre non lo era fra novembre e marzo, a causa del mal tempo, e nei mesi estivi, dato che in estate alcune zone erano quasi secche. Una volta che le navi raggiungevano Ostia le merci venivano scaricate e imbarcate sui battelli fluviali, gli stessi risalivano la corrente del fiume per mezzo di una tecnica chiamata alaggio, essa sfruttava la forza di alcuni buoi che, dalle due rive del fiume, trainavano le piccole imbarcazioni grazie a delle corde. Vi erano lungo il fiume stazioni di sosta per permettere ai buoi e alle persone di riposare, mediamente queste stazioni dovevano trovarsi a circa 11 km l’una dall’altra, identificarle è estremamente difficile dato che nel corso del tempo il Tevere ha più volte cambiato il suo percorso e i vari lavori edilizi, compiuti a partire dal XIX secolo, ne hanno cancellato quasi completamente ogni traccia. Infine è da menzionare l’esistenza a Roma di un ufficio i cui funzionari erano addetti alla manutenzione del fiume, ne permettevano un’agevole navigazione e limitavano gli effetti devastanti delle inondazioni. Questi funzionari erano detti curatores riparum et alvei Tiberis a cui poi si aggiunse il termine et cloacarum urbis. Tuttavia le fonti letterarie sono discordi sulla data di istituzione di questo ufficio, secondo Svetonio esso sarebbe stato istituito da Augusto nei primissimi anni dopo cristo, mentre Dione Cassio riporta la data del 15 d.C. attribuendo a Tiberio l’istituzione di questo ufficio. Terminata questa introduzione archeologica sul Tevere si procederà ad analizzare il problema della circolazione monetaria lungo il fiume tenendo conto dei dati raccolti durante la tavola rotonda dell’86 e pubblicati nel Bollettino di Numismatica n. 9 dell’87. Per ragioni di spazio non sarà possibile dilungarsi troppo negli approfondimenti, pertanto si cercherà di essere sintetici. “Nella sua introduzione Gorini suddivide i ritrovamenti monetali in due categorie: i ritrovamenti singoli e i ritrovamenti multipli”[2].
“Passando ora ai metodi di indagine, l’autore descrive le modalità con cui le monete possono essere studiate in senso stratigrafico, topografico, statistico e storico-economico”[3]. Si prosegue analizzando il problema riguardo alla monetazione delle città e dei popoli preromani dell’Italia antica, al loro passaggio nell’orbita romana e, infine, il problema dell’introduzione del denario. “In questo caso gli scavi di Morgantina, e i ripostigli siciliani connessi con la seconda guerra punica, sembrano propendere per la data del 212 a.C., ma si attendono nuovi sviluppi per chiarire il problema”[4]. L’intervento di H. M. von Kaenel tratta delle monete ritrovate nel Tevere negli anni fra il 1877 e il 1890, durante i lavori di sistemazione degli argini del fiume e ora conservate presso il Museo Archeologico di Palazzo Massimo. Alcune di esse potrebbero essere parte di offerte votive ma per lo più sono monete perse accidentalmente, quasi tutte in bronzo dato che, come detto in precedenza, le monete in metallo nobile venivano custodite con cura. A livello statistico le monete maggiormente rappresentate appartengono al primo periodo imperiale: 800 monete di Ottaviano Augusto, 1.200 monete di Tiberio, 500 di Caligola e 900 monete di Claudio. Da Nerone in poi il numero delle monete coniate non raggiungerà più i valori delle monete dei primi imperatori. Segue poi l’intervento di M. R. Alfondi che approfondisce la tematica dei ritrovamenti monetali e chiarisce l’importanza dello studio delle monete entro il loro contesto archeologico. Di seguito l’intervento di F. P. Rosati in merito al ritrovamento di tesoretti monetali, la studiosa ribadisce l’importanza che i tesoretti siano conservati integri per uno studio completo sul contesto archeologico del sito, tuttavia come detto dalla Rosati, un ripostiglio di monete, anche se incompleto e isolato dal contesto archeologico, può comunque fornire dati generici sulla circolazione monetaria nella regione. L’intervento di S. Moscati, con le sue conclusioni sull’intervento di Rosati, conclude la Tavola Rotonda svoltasi nel complesso di San Michele a Ripa nel 1986. Il più consistente ritrovamento è stato quello delle circa undicimila monete, rinvenute durante i lavori di sistemazione dell’alveo del fiume e la costruzione degli argini, negli anni fra il 1877 e il 1890 ora conservate presso il Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. L’inventario delle monete ebbe inizio ad opera della Secondina Lorenza Cesano nel 1903 e si concluse nel 1923, con la catalogazione di 11.183 monete. Nel 1984 fu data una prima notizia, delle monete ritrovate nel Tevere, ad opera di H. M. von Kaenel sulle monete di Claudio I nel BdN n. 2-3; una seconda notizia ci fu nel 1988 ad opera di F. E. Koenig, sulle monete di Caligola nel BdN n. 10 e, in fine, una terza notizia fu data nel 1995 ad opera di S. Frey Cupper, sulle monete greche nel BdN n. 25. Seguiremo l’ordine cronologico delle monete, iniziando con le greche per poi continuare con Caligola e infine Claudio. “Le monete greche sono 122 corrispondenti all’1,1% del totale delle monete tiberine, queste formano uno degli sporadici ritrovamenti di monete greche a Roma, a titolo di esempio si può citare il tesoretto di 108 monete greche che Richard Marsden Reece cita nel suo articolo “A Collection of Coins rom the Center of Rome, dell’82”[5]. “Le monete provenienti dall’Italia e dalla Sicilia rappresentano la maggioranza sul totale degli esemplari, la sola Sicilia conta 53 pezzi, 7 dalla Sardegna, mentre la Grecia è rappresentata solamente da 9 pezzi, altre monete provengono invece dalla Hispania, Illyria, Pontus, Paphlagonia, Ionia, Caria, Cyrenaica e Zeugitania”[6]. Nel suo articolo la Kupper si è concentrata sulle monete di Paestum, Syracuse, Cos, Panormus e di Cartagine, in quanto in esse si riscontra una scelta limitata riguardo ai tipi e ai nominali (48 pezzi) costituiscono da sole il 40 % di tutto il materiale, inoltre la Kupper precisa, con due motivazioni: “La prima è che è stato ipotizzato che le monete provenienti dalla Grecia fossero parte di offerte votive o bottini di guerra in quanto sarebbe stato decisamente insolito il ritrovamento di singole monete in territori tanto lontani dalla loro madrepatria. La seconda è il fatto a dir poco curioso della totale mancanza di monete bronzee di Neapolis del III sec. a.C. o di altre campane o sannitiche, inoltre sono assenti le monete provenienti dalle colonie romane del Sud Italia”[7]. A seguire tratteremo delle cinque zecche studiate dalla S. FreyKupper nel suo articolo sui ritrovamenti greci nel Tevere, esse sono Paestum, Panormus, Syracusae, Cartago e Cos: Paestum Le monete provenienti da Paestum sono sette, nel catalogo della Cesano corrispondono alle monete nn. 2-8 e si suddividono in tre tipi monetali: i primi due sono, un triente e un semisse, risalenti al periodo in cui nella città campana governava un collegio di quattro magistrati detti quattuorviri, mentre il terzo tipo è rappresentato dalle cinque monete recanti i nomi dei duoviri e sono tutti semissi. Sul rovescio dei cinque semissi compaiono due leggende; “Q[.]OR” e “NAV” da identificarsi come i nomi dei duoviriri e da interpretarsi come “Quintus Porcios”, “Numerius Aurelius” oppure “Numerius Aufidius”. Tutti e tre i tipi appartengono al I secolo a.C.; le monete, che al dritto recano un busto galeato e al rovescio le mani incrociate con legenda, servivano solo per uso locale e il loro valore era molto basso, esse equivalevano a un quadrante romano. Oltre alle monete n. 2-8 ve ne sono altre due di identificazione incerta: La n. 9 con al diritto Hermes e legenda “Q[.]OR” e mani incrociate sul rovescio sarebbe da attribuire a Paestum se non fosse che non si conoscono altre monete con l’identica combinazione di conii, il SNG di Copenaghen lo attribuisce alla zecca di Panormus. Sulla moneta n. 10 compare lo stesso identico conio di diritto con il busto di Hermes della moneta n. 9, al rovescio, un guerriero alla cui sinistra compare la leggenda “NAV” anch’essa attribuita, dal SNG di Copenaghen a Panormus. Dato che per queste due monete è stato usato lo stesso conio di diritto attribuibile a Paestum, l’identificazione di queste due monete come monete di Panormus risulterebbe sbagliata. Panormus Dopo le monete di Paestum la Kupper passa ad analizzare le monete provenienti da Panormus; esse sono omogenee fra di loro per quanto riguarda tipologia, peso e dimensioni, e sono numerate nel catalogo della Cesano dal n. 28 al n. 32. Recano sul diritto la testa di Zeus e sul rovescio la figura di un guerriero e sono databili ad un periodo compreso fra la fine del II sec. a.C. e gli inizi del I sec. a.C. La loro circolazione era esclusivamente locale, pertanto è probabile che le monete appartenessero ad un unico complesso, borsa, gruzzolo o altro. Oltre a queste monete è presente una variante catalogata come moneta n. 33, essa presenta la testa di Zeus a diritto e un tempio tetrastilo. Secondo la Kupper vi sarebbero anche delle imitazioni nel gruppo nn. 28-32, sono tre monete catalogate dal n. 16 al n. 18, forse sono state prodotte nel centro Italia, dato che in Sicilia non sono stati ritrovati esemplari simili a parte un’unica moneta ritrovata a Morgantina. Syracusae Le monete di Siracusa appartengono a due gruppi monetali, il primo che comprende le monete nn. 34-43, il secondo le monete nn. 44-65. Il primo gruppo, con diverse tipologie di dritto e rovescio a seconda dei sovrani, copre un arco cronologico che va da Dioniso I (405 – 367 a.C.) a Agatocle (317 – 289 a.C.), con una forte presenza di monete di quest’ultimo. Assenti, invece, le monete di Ierone II (270 – 215 a.C.) e poche sono le monete databili dal tempo di Iceta (288 – 279 a.C.) alla fine della seconda guerra punica. Il secondo gruppo, più numeroso, comprende le monete nn. 4465, risalenti al periodo di dominazione romana. In esso spiccano 15 monete (nn. 51-65), con testa di Core al dritto e Demetra al rovescio, le stesse compongono il 12% del materiale studiato dalla Kupper. Le città siciliane sotto il dominio romano furono caratterizzate da un’intensa produzione monetale sia quantitativa che qualitativa. L’omogeneità tipologica delle monete siracusane ci fa supporre che dovevano appartenere allo stesso complesso, come quelle di Paestum, come ad esempio un tesoretto. Cartago La maggior parte delle diciannove monete puniche provengono da Cartagine e costituiscono il 15.5% del campione. Includendo la n. 1, vanno dalla n. 69 alla n. 78 e dalla n. 114 alla n. 121, per un totale di 19 monete. La maggior parte delle monete appartiene al periodo precedente alla prima guerra punica (264-241 a.C.), e recano sul diritto la testa di Tanit e sul rovescio il cavallo davanti ad una palma, tipico della monetazione punica. Gran parte di queste monete non erano più in circolazione dopo la seconda metà del III secolo a.C. La varietà tipologica delle monete enee provenienti da Sicilia, Sardegna e Spagna meridionale, tutti luoghi sotto il dominio cartaginese, e ritrovate nel Tevere lascia pensare che esse fossero venute fuori in contesti singoli, solo le sette monete nn. 72-78, in virtù della loro omogeneità, lascia pensare che facessero parte di un insieme. Cos L’ultima zecca trattata dalla Kupper è quella di Cosa, le tredici monete di questa zecca, nn. 100-112, sono tutte databili fra il 167 a.C. e l’88 a.C. e recano sul diritto la testa di Eracle, posto di tre quarti, e al rovescio la Clava con Goritos. Sembrerebbe che le monete di Cosa abbiano a che fare con il santuario di Esculapio sull’isola Tiberina, l’omogeneità tipologica delle monete però esclude quest’ipotesi, poiché un’offerta votiva si accumula nell’arco di molti anni ed è caratterizzata da una forte eterogeneità di monete provenienti da zecche più o meno lontane e di diversi periodi storici. Pertanto le caratteristiche del campione lasciano supporre che le monete fossero parte di un tesoretto selezionato con attenzione dal suo proprietario. I prossimi due articoli riguarderanno le monete degli imperatori Caligola e Claudio rispettivamente di F. E. Koenig e H. M. von Kaenel. Nel 1988 uscì l’articolo di F. E. Koenig sulla circolazione monetaria all’epoca dell’imperatore Caligola pubblicato nel volume n° 10 del Bollettino di Numismatica dell’istituto poligrafico dello stato. “Il complesso monetale di Caligola risulta essere il secondo per dimensioni sinora rinvenuto come mostra la lista delle località di ritrovamento. Non sono state identificate monete in metallo nobile di questo imperatore ma solo monete in rame e oricalco. Il nominale più frequente è l’asse mentre quello meno frequente è il dupondio, scarsi sono invece i sesterzi. Riguardo alle tipologie del dritto e del rovescio, per i sesterzi il tipo più frequente è quello con il ritratto di Agrippina seguito dal tipo con le tre sorelle sul rovescio che chiudono la serie. Nei dupondi il tipo con il Divo Augusto supera quantitativamente i tipi di Nerone e Druso Cesari e quelli di Germanico, quest’ultimo presente in numero ancora più ridotto. Per gli assi il tipo con Agrippina è maggioritario rispetto ai tipi con Caligola che supera solo di poco quello di Germanico. A causa dell’usura delle monete, non è stato possibile stabilire in quale nominale sia stato intenzionalmente cancellato il nome di Caligola a causa della Damnatio Memoriae subita dall’imperatore”[8]. La prova della cancellazione di un ritratto o della legenda mediante l’uso del martello è evidente nell’appiattimento della superfice sull’altro lato della moneta. Sul totale delle monete provenienti dal Tevere 244 presentano tracce di martellamento, la maggior parte sono sesterzi di Caligola mentre gli altri sono quasi tutti assi con l’effige di Germanico. “Per quanto riguarda le contromarche, le monete che le portano impresse sono molto poche, l’autore ne ha identificate due differenti”9. Le contromarche si possono suddividere in due gruppi:
Dopo aver trattato delle monete di Caligola, studiate da Koenig, ci concentreremo sulle monete di Claudio, studiate da Kaenel, il cui articolo fu pubblicato nel volume precedentemente trattato, il Bollettino di Numismatica n. 2-3 dell’84. Come già detto in precedenza le fonti numismatiche ci dicono molto sulla circolazione monetaria nelle province settentrionali o occidentali nei secoli III e IV d.C. ma sono scarse per quel che concerne la circolazione monetaria in Italia. “Data la scarsità di ritrovamenti monetari a Roma, a comparazione con altri luoghi, oltre alle monete tiberine si possono citare, fra i più importanti ritrovamenti monetali a Roma, due collezioni numismatiche di grande importanza. La prima collezione è composta dalle 46.000 monete, in bronzo e rame, conservate nel magazzino delle collezioni comunali del Campidoglio e ritrovate fra il 1872 e il 1900, purtroppo per queste monete manca a tutt’oggi un catalogo che permetta una rapida identificazione. La seconda collezione è composta da 5000 monete ora custodite nell’antiquarium del Palatino e ritrovate nell’area del Palatino e del Foro Romano, queste ultime son state di recente studiate da R. Reece”[9]. Ritornando alle monete del Tevere possiamo affermare che sono importanti per due motivi: Il primo riguarda i 650 conii attraverso i quali si può risalire ai magistrati monetari di epoca augustea, questi conii costituiscono il ritrovamento più importante dopo quello di Vindonissa in Svizzera, e ci aiutano a identificare i vari collegi monetari che si sono succeduti nel corso del tempo. Il secondo riguarda le monete bronzee di Claudio, esse rappresentano, dopo quello del fiume Maienna (Saint Léonard-Francia meridionale), il più grande complesso monetale di questo imperatore. Le monete imperiali ritrovate nel Tevere costituiscono la più alta concentrazione di monete di questo periodo, concentrazione superiore anche ai ritrovamenti del Campidoglio e del Foro Romano. Si procederà ad un’analisi tecnica delle monete e delle contromarche che compaiono con maggior frequenza sulle monete di Claudio. Fra le monete enee, considerate dall’autore, non sono presenti monete con l’effige di Germanico. Fra le monete in oricalco mancano gli esemplari con le effigi di Britannico, Agrippina minore e Nerone. I suddetti tipi, rari a Roma, venivano coniati da zecche della provincia di Tracia. Le unità in oricalco, sesterzi e dupondi, ammontano complessivamente a un quinto del campione mentre gli assi e i quadranti, in rame, compongono i restanti quattro quinti. Il nominale più frequente, in base agli studi dell’autore, è l’asse mentre il meno frequente è il dupondio. Tre sono i quadranti (343-344-345) che, in base alla loro titolatura, sono databili al periodo compreso fra l’assunzione del secondo consolato di Claudio e l’assunzione del titolo di Pater Patriae dell’imperatore (41-42 d.C.). Gli esemplari di Claudio si possono suddividere in due grandi emissioni, la prima senza la titolatura Pater Patriae e la seconda con questa titolatura. Le due emissioni, come dimostrato dall’autore, non si equivalgono, infatti i sesterzi della seconda emissione sono numericamente inferiori alla prima e questo divario rimane anche quando, alla seconda, si aggiungono i sesterzi di imitazione. Al contrario per gli assi è la seconda emissione con la titolatura Pater Patriae a essere superiore alla prima di quasi il doppio, infine per i dupondi non sono state evidenziate grandi discrepanze numeriche. Dopo due brevi paragrafi su il peso e sulla posizione dei conii di dritto e rovescio, l’autore del presente articolo, H. M. von Kaenel, introduce l’argomento sulle contromarche presenti su alcune di queste monete. Una delle due contromarche che appare più di frequente è la sigla NCAPR, impressa là dove la contromarca non copre l’immagine. “La contromarca NCAPR e stata studiata in maniera esaudiente da Mac Dowall. Sui sesterzi veniva applicata in genere sul rovescio mentre sui dupondi sul diritto, orientata in maniera diversa a seconda dell’orientamento dell’effige raffigurata; secondo lo studioso Dowall la stessa contromarca era presente sulle monete in oricalco di Tiberio mentre era assente su quelle di Caligola, probabilmente a causa della dannatio memoriae subita da questo imperatore. La suddetta contromarca compare sia sulle monete senza titolatura Pater Patriae sia su quelle con la titolatura, in percentuali uguali, il che ci aiuta nella datazione dell’intero campione. Lo studioso avrebbe poi ipotizzato che la zecca producente le monete con questa contromarca dovesse trovarsi nell’Italia settentrionale, tuttavia quest’ipotesi sarebbe priva di fondamento e si preferirebbe optare per la stessa Roma”[10]. La datazione della contromarca NCAPR è di epoca neroniana e il significato della prima parte “NCA” sarebbe riconducibile a Nero Caesar Augusti. Più difficile è l’interpretazione di “PR”, potrebbe significare Populus Romanus oppure, per analogia con la contromarca PROB, PRobatum. “Il Kraay farebbe risalire l’inizio dell’apposizione di questa contromarca al Congiarium di Nerone, nell’anno 57 a.C. Mac Dowall, dal canto suo, farebbe risalire l’inizio dell’apposizione di questa contromarca alla riforma monetaria di Nerone in cui, fra le altre cose, la monetazione in rame passò ad essere interamente in oricalco e fu necessario apporre questa contromarca per distinguere le nuove monete dalle vecchie. Diversamente dalla prima contromarca, sulla seconda PROB, le cui monete sono state studiate dal Kraay, non sono stati pubblicati molti studi e il suo significato rimane ancora incerto. Ad ogni modo la contromarca PROB, secondo il Kraay, grazie ai ritrovamenti sembrerebbe maggiormente attestata in Inghilterra, mentre non vi sarebbero tracce di monete con questa contromarca né a Neuss né a Vindonissa”[11]. Passando all’articolo successivo si tratterà del materiale numismatico rinvenuto lungo le sponde del Tevere nell’ultimo secolo. Le monete, rinvenute in diversi siti (A, B, C, D, E), furono studiate da Lucia Travaini e Roberto Meneghini che successivamente pubblicarono i risultati della loro ricerca nel BdN n° 5 dell’85. La ricerca fu basata quasi esclusivamente su materiale d’archivio più o meno dettagliato per i siti A, D, E, mentre per il tesoretto del sito C, rinvenuto presso via Bodoni, fu possibile incrociare i dati del materiale d’archivio con una più accurata documentazione numismatica, tuttavia fu impossibile ricostruire la corrispondenza precisa fra evidenza archeologica e materiale numismatico. In via Salaria, nel 1888, corrispondente al sito A, furono rinvenuti 13 trienti: 2 di Roma, 3 di Sutri e gli altri 8 da località laziali non identificate. Diverso ed esemplare fu il caso del sito B, per il quale ogni reperto proveniente da un contesto ben definito è collegato con gli altri. Nel sito B, durante gli scavi di Lungotevere Testaccio, negli anni fra il 1979 e il 1983 furono rinvenuti 180 reperti numismatici che furono consegnati al Gabinetto Numismatico del Museo Nazionale Romano e catalogati con i numeri da 363.665 a 363.844. Il materiare è costituito da 175 monete, 3 tessere plumbee e 2 oggetti non monetali. Delle 175 monete, di cui 10 non identificate, circa la meta sono monete di bronzo dei secoli IV e V d.C. Fra le monete tardo imperiali 63 sono databili fra il 337 e il 408 d.C., di cui 5 non identificate, 32 sono databili fra il 253 e il 299 d.C., e costituiscono rispettivamente il 39% e il 18% delle 175 monete del sito B. Fra il materiale numismatico vi è anche un medaglione in bronzo di Marco Aurelio, un sesterzio in bronzo martellato di Filippo I l’arabo e un tondello non coniato del V – VI sec. d.C. Gli ambienti nei quali si è scavato sono quelli del criptoportico (P, Q, U), retrostanti alla pavimentazione in lastre di travertino (K, R, S), la stessa pavimentazione di uno dei quattordici vani riempitivi di essa (ambiente XI). Per quanto riguarda il sito C, il tesoretto in esso rinvenuto fu portato alla luce il 20 ottobre 1911, durante i lavori per la costruzione delle case popolari in via Bodoni. La notizia della scoperta fu pubblicata in Notizie dagli Scavi e sul Bollettino Comunale di Roma nello stesso anno, mentre la presentazione del materiale numismatico fu pubblicato da Lorenzina Cesano nel 1919 in Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica n° 3. Le monete identificate sono 804, di cui 611 in bronzo e 193 in mistura, databili in un periodo compreso fra l’età di Augusto (I sec. d.C.), e l’età di Gallieno (metà del III sec. d.C.). Oltre alle monete sopra elencate furono ritrovati 84 pezzi in pessimo stato di conservazione che non furono né identificati né inventariati dalla Cesano ma che in futuro, grazie al progredire della scienza, potranno esser studiate e identificate con certezza. Nel sito D, nel 1907, durante i lavori di costruzione del Ponte Ferroviario che collegherà le stazioni di Roma Trastevere e Roma Termini, sotto il pilone destro, furono rinvenute 21 monete di bronzo di cui: 1 anonima; 2 di Nerone; 1 di Vespasiano; 1 di Tito; 3 di Domiziano; 1 di Adriano; 2 di Marco Aurelio; 1 di Massenzio; 1 di Costantino I e 8 illeggibili. Presso il Ponte dell’Industria, corrispondente al sito E, ultimo della lista, furono rinvenute, durante i primi lavori di sbancamento degli argini fluviali nel 1878/1879, centinaia di monete in bronzo e argento, di epoche e luoghi talmente diversi fra di loro che il Comune di Roma dovette impegnare i suoi dipendenti per tre mesi nell’attività di setacciatura e catalogazione delle monete che furono annotate nei Registri Territoriali, sezione Antichità Comunali. Bibliografia CARPANO 1984 = CARPANO MOCCHEGIANI CLAUDIO, Bollettino di Numismatica n. 2 – 3, IPZ, Roma 1984. GORINI 1985 = GIOVANNI GORINI, Bollettino di Numismatica n. 5, IPZ, Roma 1985. GORINI 1987 = GORINI GIOVANNI, Bollettino di Numismatica n. 9, IPZ, Roma 1987. KAENEL 1984 = VON KAENEL HANS MARKUS - Bollettino di numismatica n. 2-3, IPZ, Roma 1984. KOENIG 1988 = KOENING FRANZ E., Bollettino di Numismatica n. 10, IPZ, Roma 1988 KUPPER 1995 = FREY-KUPPER SUZANNE, Bollettino di Numismatica n. 25, IPZ, Roma 1995. [1] CARPANO 1984, pag. 47. [2] GORINI 1987, pag. 12. [3] - GORINI 1987, pag. 14. [4] GORINI 1987, pagg. 14–15. 5- Pubblicato in Papers of the British School at Rome, volume 50. 6- KUPPER 1995, pagg. 33–34. 7 - KUPPER 1995, pagg. 35–38. 8 - KOENIG 1988, pagg. 23–27. 9 9 KOENIG 1988, pagg. 28–30. 10- KAENEL 1984, pag. 91. 10- KAENEL 1984, pag. 99 – 101. 11 - KAENEL 1984, pag. 101-103. A spasso nell’Etruria moderna. Zaira, una sorpresa inaspettata Irene Salvatori La Toscana è una terra di bellezza e di sorprese. Con grande orgoglio posso dire che una metà di me appartiene a questa terra, l’altra metà è romana. C’è un paesino, Piazze, frazione di Cetona, che da sempre custodisce parte del mio cuore. Qui ho trascorso i momenti più felici della mia adolescenza e qui c’è parte della mia famiglia. Cetona è un mondo incantato, un piccolo borgo tutto pepe con un importante sito archeologico preistorico. Ho girato queste zone in lungo e in largo perchè Cetona è un posto strategico: è praticamente vicina a tutto. Basta prendere la macchina e in breve ci si trova a Montepulciano, Pienza, Siena, Chiusi, Citta della Pieve e Perugia. Questa è una parte dell’Etruria moderna. Il tempo è stato benevolo con questa terra. Il trascorrere dei secoli non ha intaccato la magnificenza di questi luoghi, anzi. Archeologia e natura hanno creato un sodalizio indissolubile e, tra vigneti e uliveti, ecco emergere il Borgo fantasma di Salci, dove tutto è immobile e la storia sembra riassunta nell’affascinante “loggia degli Spiriti”. E poi i borghetti medievali di San Casciano dei Bagni, con le splendide terme e Sarteano, o il Castello di Fighine. Poco lontano da Piazze c’è lei, Chiusi, la terra del leggendario re Porsenna, la regina di un glorioso tempo passato. Se andate a Chiusi sono due le cose da fare assolutamente. La prima è la passeggiata archeologica che dal Museo Etrusco (che conserva reperti di un’importanza unica), vi porta alle tombe e ai sotterranei della città, detti “Labirinto di Porsenna”, una serie di gallerie scavate per l’approvigionamento idrico della città con cisterne etrusco-romane. Oggi, un’attenta politica di valorizzazione culturale ha reso accessibile gran parte delle tombe e dei sotterranei...è consigliabile portarsi un golfino perchè l’umidità taglia le gambe. Sempre al Museo un servizio navetta vi porta alle tombe della Scimmia e della Pellegrina che gli amanti dell’archeologia non possono non vedere. Sono tombe ipogee alle quali si accede scendendo un dromos, corridoio; la prima dell’inizio del V secolo a.C. è famosa per un ciclo di affreschi parietali con giochi di atleti e di bighe dove compare anche una scimmia, da cui il nome. L’altra, del IV-III secolo a.C. appartenuta alla famiglia dei Sentinates, ci ha lasciato ancora in situ 5 sarcofagi e 12 urne in alabastro e travertino. E ancora, la Tomba delle Iscrizioni e del Leone. Al ritorno di una delle mie passeggiate, affamata chiedo al mago della ricerca dei ristorantini tipici, mio marito, di fermarci per una sosta mangereccia. Et voilà ecco che nella mia vita entra Zaira, un locale al centro di Chiusi dove mangiare non è solo esperienza culinaria ma un viaggio nel tempo. Entro e chiedo “avete i pici?”. Una voce dietro di me risponde: “noo, non siamo mica in Toscana”. Mi volto e vedo un giovane simpatico, Marco. Mi piace la sua ironia e già pregusto un buon pranzetto. La proposta di Marco è una cucina tipica toscana leggermente modernizzata. Prodotti d’eccellenza e sapori che mi ricordano l’infanzia, con una strizzatina d’occhio alla sperimentazione. Chiacchierando scopro che la gestione è cambiata da poco. Marco e la moglie Dailin sono ospiti brillanti e amichevoli. Dailin mi incanta. E’ di origini cubane e ha un sogno, portare un po’ della sua terra in quel di Toscana. Il motto di Zaira, per altro già storico ristorante chiusino, è “mi casa es tu casa”, vale a dire: venite, sorridete, mangiate, bevete e godetevi la vita. Poi la sorpresa. Come nulla fosse Marco mi mostra il secondo motivo per cui andare a Chiusi. Armato di lampada ci fa cenno di seguirlo in quelle che, da una breve descrizione, sono le cantine del ristorante ma che, a vederle dal vivo, risultano delle grotte quasi labirintiche. Scendendo mi trovo davanti un mosaico tardo antico e comincio a vacillare. Di gradino in gradino vengo proiettata all’epoca degli Etruschi. Alla fine della scala davanti a me, a perdita d’occhio, una distesa di bottiglie da collezione che spaziano dal Brunello al Barolo, da rare annate di Gigondas a bottiglie di Porto riserva. Uno sguardo a mio marito e capisco di averlo perso. Guardo i soffitti delle grotte e hanno la stessa stratigrafia dei cunicoli del Labirinto di Porsenna. Marco mi spiega che sotto molti edifici di Chiusi ci sono situazioni come queste, ma che quella di Zaira è una delle realtà meglio conservate. Mi aggiro nella penombra e sono rapita. Nel frattempo cerco il consorte e lo vedo che guarda, tocca, annusa e sembra cercare un angolino da dove dire “lasciatemi morire qui!”. Passo oltre e con un solo sguardo abbraccio la ricchezza di questa terra, il vino e la storia secolare. Una sorpresa da non perdere, un mondo da scoprire. Risaliamo senza parole. Ad attenderci i miei agognati pici all’aglione e un eccellente filetto di chianina. Zaira è un mondo, una scoperta. Vi consiglio vivamente di farci un salto. In una botta sola avrete ottima cucina, bella selezione di vini, la storia a portata di mano e l’accoglienza unica di Marco e Dailin, perchè per loro “mi casa es tu casa” non è un modo di dire, ma un modo di essere. LA CULTURA A 360 GRADI.
“Tramonti e muffati”. La ricerca della tradizione più autentica Irene Salvatori Roma è sempre una scoperta. Ogni angolo trasuda storia e arte. Sono un’archeologa e una persona curiosa, con l’immensa fortuna di condividere la mia vita con una persona che, come me, apprezza la bellezza. A mio marito, e di questo non lo ringrazierò mai abbastanza, devo l’apertura dei miei orizzonti verso altri lidi, e con lui ho ampliato il mio concetto di ciò che significa Cultura. Visitare paesi e città significa esplorarne ogni sfumatura che sia archeologica, artistica o... eno-gastronomica! E su questo, amici, possiamo dire di non essere secondi a nessuno. Da nord a sud è un trionfo di gusti e di sapori, di prodotti tipici e vini che sono il vanto dell’Italia nel mondo. Ebbene, anche se con po’ di ritardo, ci sono arrivata anche io. Non che prima non apprezzassi il buon cibo o il buon vino; semplicemente pensavo che fossero aspetti marginali, a sé stanti. Nulla di più sbagliato. La storia di un popolo è anche e soprattutto la storia della quotidianità, delle tradizioni e degli usi alimentari. Tanto è stato scritto sull’alimentazione nell’antichità e tanto ancora da scrivere. Una ricerca di questo tipo investe molteplici aspetti, dallo studio del vasellame a quello dei traffici commerciali, alla storia delle colture e della tecnologia agricola...al semplice piacere del vivere nel corso dei secoli. Tornando ai nostri giorni e alla mia scoperta dell’acqua calda, con l’entusiasmo del bambino che scopre un nuovo gioco, mi sono immersa nella ricerca di nuovi sapori, di nuove prospettive del gusto. “Irene ti va di assaggiare questo vino? Ho visto che c’è un delizioso localino andiamo?” “Si, certo... vabbhe tanto da lunedì dieta. Vamos!!!” E così tra un giro esplorativo e un bicchiere di vino ho capito due cose: la prima, che non mi piacciono i locali affollati, la seconda che amo gli autentici sapori regionali, quelli che sanno di casa e hanno un passato, una storia da raccontare. Consapevole di questo, la mia metà mi ha portato, un po’ di tempo fa, in un posticino zona Appia-Tuscolana, “Tramonti e Muffati”. Un’epifania! Un piccolo bistrot, raccolto, intimo dall’arredo essenziale. Pochi tavoli, musica da camera in sottofondo, ma soprattutto lui, Marco, che con mix di affabilità e riservatezza da gentiluomo d’altri tempi, accoglie gli ospiti con sommesso “benvenuti”. Il tempo da Tramonti e Muffati si ferma o meglio il tempo è di nuovo nostro. Fermiamoci e rilassiamoci. Finalmente lontani dalla velocità sfibrante della metropoli cominciamo il nostro viaggio tra la semplicità e la riscoperta dei prodotti più autentici del nostro territorio, cercati ad uno ad uno, con infinita pazienza, nelle piccole realtà agricole del Lazio e non solo. Di ogni piatto Marco narra la provenienza e la storia. Qualche sera fa, davanti ad una bottiglia di vino piemontese ho voluto togliermi qualche curiosità e ne è nata questa intervista che vi consiglio di leggere perché vi dice molto e del locale e del suo “oste”. CIAO MARCO, E’ SEMPRE UN PIACERE VENIRE NEL TUO LOCALE. MI HA SEMPRE INCURIOSITO IL NOME. MUFFATI E’ INTUITIVO MA TRAMONTI? Quando ho aperto con mia sorella, nel 1997, i pochi locali romani di questo genere avevano adottato un nome che evocasse direttamente il vino, oppure il cognome di famiglia affermato da tempo nel settore. Al termine di un buon Barolo, finimmo con il formulare una strampalata via di mezzo: Tramonti & Muffati può evocare un binomio professionale, come se ne usano spesso nell'arte o nella moda, mentre in realtà il muffato è una tipologia di vino da meditazione e, con un po' di astrazione, un bel tramonto può suggerire lo stato d'animo con il quale apprezzarlo. ENTRANDO SI E’ACCOLTI DA UN’AVVOLGENTE ATMOSFERA DA BISTROT, RACCOLTO E INTIMO. UNA SCELTA DI GUSTO BEN PRECISA. COME NASCE QUEST’ESPERIENZA? Anche l'atmosfera, che cortesemente definisci intima e raccolta, nasce da suggestioni diverse: innanzitutto l'amore per le osterie di quartiere già scomparse, ma che da bambino ricordo numerose. D'altro canto avevamo la necessità di evitare il rischio che la nostra proposta fosse fraintesa con quella del cibo alla buona e del vino sfuso. Sono cambiate molte cose da allora, quando Slow Food muoveva i primi passi e il prodotto tipico non era ancora di tendenza. Molto di quel che oggi caratterizza l'ambiente che descrivi nasce in quel primo difficile periodo. Così, nel tempo, ho ritenuto prioritaria una dimensione che potesse consentire di fare quattro chiacchiere discrete e di assicurare al vino la quiete indispensabile per essere compreso. QUELLO CHE PIU’ VOLTE MI HA COLPITO E’ LA RICERCATEZZA E LA PECULIARITA’ DEI PRODOTTI CHE OFFRI E LA SCELTA DI ATTINGERE A PICCOLE REALTA’ AGRICOLE DI GRANDE QUALITA’. Ho trascorso parte della mia infanzia con i miei nonni contadini, in un piccolo e sperduto paese dell'Abruzzo, dove la prima cosa che ho appreso è stata la fatica spesa nella produzione del cibo migliore che ci si potesse permettere. COME DETERMINI CHE UN PRODOTTO SIA VALIDO? Per me l'unico prodotto valido, che si tratti di un vino, di un salume o di un formaggio, è quello che rappresenti l'unicità della cultura che lo produce interpretandone il territorio. Grazie ai miei ricordi, nonché allo studio e all'esperienza, ho imparato a riconoscere un prodotto che non sia solo genuino, ma anche ricco di profumi e di sapori. Quando si tratta di lavorazioni artigianali, infatti, due tome dello stesso tipo e dello stesso casaro possono essere molto diverse tra loro. Ciò è anche dovuto al fatto che tutti i prodotti contadini hanno una loro stagionalità, salumi compresi. NON TI LIMITI A PROPORRE UN PRODOTTO NE RACCONTI LA STORIA E LA PROVENIENZA. CONSIGLI IL PERCOSO DEGUSTATIVO Il racconto del contesto è fondamentale. Ogni prodotto, nonché il vino, nasce per essere compreso ed apprezzato nel proprio luogo di origine e non in una grande città, dove l'olfatto si chiude per difendersi dagli infiniti olezzi che lo assediano. Per questo cerco sempre di raccontare quel che servo al tavolo, illustrandone il contesto: pregustare un piatto è importante per riattivare i propri sensi liberandoli dall'assedio. PARLIAMO DI VINI, LA TUA GRANDE PASSIONE. COME NASCE? Sarai sorpresa, ma non nutro passione per il vino in sé; direi solo che ne coltivo la confidenza, perché lo considero uno strumento. Un po' come per gli archeologi: la loro passione non è per il reperto, ma per il racconto che custodisce. Ad ogni modo, grazie ai nonni che ne producevano, il vino era di casa. Uno dei miei primi ricordi è di aver pianto perché non potevo assaggiarne stando al tavolo tra adulti; allora mio padre mi mise nel bicchiere un po' di mosto appena pigiato e, di fronte alla mia ovvia perplessità, mi spiegò che quello era proprio lo stesso vino che bevevano loro, ma che era solo molto giovane, come me: quando fossi diventato un ometto, anche il mio vino sarebbe diventato grande e forte. VINO COME MODA O COME ESPERIENZA SENSORIALE? Oggi vedo molte persone appassionate del vino in sé, dell'esercizio del proprio gusto e della gratificazione sociale che questo comporta. Dimenticano che la magia del vino non sta nel liquido che lo compone, ma è sospesa in un rapporto dialettico tra il calice e chi lo beve. "Ogni vino bevuto ha il suo racconto", scriveva Luigi Veronelli, quindi la nostra capacità di leggerlo non può riassumersi nella sola facoltà di misurarne le qualità. Perciò, nonostante lo studio comunque dedicato e il bagaglio di meditati assaggi ormai invidiabile, non mi sono mai interessato alla qualifica di sommelier. Io sono un oste. Se mi ritrovassi a dover servire solo acqua e non più vino, sono certo che farei esattamente lo stesso mestiere parlando ai miei clienti di sorgenti, minerali, fontane e acquedotti. Il fine sarebbe sempre il racconto del territorio e delle comunità che ne hanno interpretato le risorse. CHI ENTRA E’ ACCOLTO DA MUSICA DA CAMERA. UN SOTTOFONDO MUSICALE ELEGANTISSIMO. QUESTA SCELTA NASCE DA UNA TUA ESPERIENZA PERSONALE VERO? Fuori del mio locale, vivo molto di musica; la suono, la ascolto, la scrivo. Dobbiamo a Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, il primo trattato (in forma epistolare) sulle diverse qualità dei vini in base alla loro provenienza. Curiosamente, questa sua lettera del 1559 risale allo stesso periodo in cui si riconosce al musicista non più il solo magistero e il diritto d'esserne l'autore, ma anche dignità di espressione artistica. MUSICA E VINO. UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE? Benché io non sia uno storico, mi sembra che l'uomo ad un tratto abbia aspirato, con la musica e con il vino, spesso goduti nella stessa occasione, ad una nuova dimensione del benessere connotata da una sorta di contemplazione finalmente laica del bello e del buono. FAI SCELTE MUSICALI PRECISE... Al netto di queste suggestioni, scelgo di proporre musica del Cinque, Sei e Settecento anche perché ha un volume più costante rispetto ad altri generi; questo ne favorisce l'uso da sottofondo che, in un locale raccolto come il mio, ritengo necessario per confondere tra le note la riservatezza delle conversazioni. Amo qualsiasi genere di musica, con rarissime eccezioni; però il barocco strumentale italiano ha avuto le sue scuole ben distinte anche sul piano geografico e, in questa varietà, trovo la liason con quella dei miei prodotti. Anche se, a volte, mi spiace di non poter usare il jazz di Basso e Valdambrini, che pure avrebbe una sua attinenza con le mie fantasie d'osteria; se non altro per il "Blues for Gassmann" e la pasta e ceci ne I Soliti Ignoti. GRAZIE MARCO. ALLA PROSSIMA! Questo è quello che intendo per Cultura a 360 gradi. Realtà come questa vanno ricercate e tutelate perchè sono parte di noi, del nostro piacere di vivere. E’ la ricerca delle nostre origini e della parte di noi che rimane più autentica. E’ cultura... solo da un altro punto di vista. LE DONNE DI BERNINI. TRA SACRO E PROFANO Irene Salvatori Nella Storia dell’Arte incontriamo bravi artisti, eccellenti artisti e i fuori classe a furor di popolo acclamati come geni. Gian Lorenzo Bernini appartiene senza alcun dubbio a quest’ultima categoria. Bernini nasce a Napoli nel 1598 e nel 1605 si trasferisce a Roma con i fratelli e il padre Pietro, scultore di una certa fama che, arrivato nell’Urbe, viene nominato presidente della prestigiosa associazione degli artisti all’Accademia di San Luca. In quel momento Roma è un cantiere a cielo aperto, ovunque chiese e associazioni religiose sono alla ricerca di scultori e architetti per decorare e rinnovare i sacri edifici, nell’ambito della ritrovata ed energica religiosità della Controriforma. Il giovane Lorenzo respira arte e polvere di marmo già in tenera età e sembra abbia dato prova del suo genio da enfant prodige già da adolescente. A Roma il soglio papale è retto con fermezza da Paolo V Borghese il quale, venuto a conoscenza delle doti del ragazzo a mezzo del nipote Scipione, lo introduce nel mondo delle commissioni che contano. Oggi visitando la Galleria Borghese, vanto di Roma e patrimonio riconosciuto del Mondo, tra le infinite opere dei più grandi maestri possiamo ammirare due gruppi scultorei e i primi due personaggi femminili sui quali vorrei soffermarmi: Dafne e Proserpina. Tra sacro e profano /privato e pubblico, Bernini ama con passione le donne e, al contempo, le sublima immergendole in un’aura di estatica bellezza. La Dafne e la Proserpina sono lavori di un poco più che ventenne Gian Lorenzo. Grande il richiamo alla classicità delle forme ma altrettanto evidente è la ricerca della luce e dell’effetto teatrale e illusionistico, per i quali il nostro protagonista è passato alla storia e per i quali è considerato il grande maestro del Barocco. Dafne, associata ad Apollo racconta un episodio delle metamorfosi di Ovidio in cui il dio, invaghitosi della ninfa, cerca di possederla, ma la fanciulla, pur di non sottostare alla violenza del divino inseguitore, chiede aiuto al padre Peneo, dio del fiume. Il padre la trasforma dunque in un albero di alloro. Il gruppo racconta quest’ultima parte della storia. L’insieme statuario nasce non solo per narrare ma per rendere partecipe chi guarda della tragedia in atto. L’osservatore si fa testimone ed è chiamato ad interagire attivamente nella vicenda della quale coglie, girando intorno al gruppo scultoreo, il momento della corsa, del raggiungimento della fanciulla e, immediatamente dopo, la sua trasformazione. Il pathos sul volto di Dafne è magistrale, il senso del movimento è ovunque, dal drappo del dio e dalla gamba alzata di questi, ai capelli della donna. Il giochi di luce e ombra e l’alternanza di pieni e vuoti creano un insieme drammatico e armonico. Alla concentrazione di Apollo si contrappone il volto mobile di Dafne, dalla cui bocca esce un ultimo e strozzato grido di terrore. Quest’opera fu terminata nel 1625 e ebbe subito il plauso entusiasta dei contemporanei. Sulla base della statua è inciso un distico composto da Maffeo Barberini, scritto per poter far entrare un’opera di chiara matrice profana nella casa di un cardinale “chi ama seguire le fuggenti forme dei divertimenti, alla fine si trova foglie e bacche amare nella mano”. Ancora nella Galleria, possiamo vedere un’altra scena di grande pathos nell’altra celebre scultura di Plutone e Proserpina. Chiunque veda quest’opera rimane incredulo nel pensare che davvero sia di marmo, devo ammettere che anche io rimango incredula e ammirata ogni volta. Il gruppo fu scolpito tra il 1621 e il 1622, commissionato dal cardinal Scipione per il cardinal Ludovisi. Nel 1908 fu comprato dallo Stato italiano e da allora è nuovamente nella Galleria Borghese. La storia è nota, e attinge ancora una volta a quel repertorio mitologico tanto amato dalla committenza intellettualmente brillante del diciassettesimo secolo. Plutone, dio degli Inferi rapisce Proserpina, figlia di Gea, la terra. Gea chiede l’intercessione di Giove per far tornare per metà dell’anno la figlia nel mondo dei vivi. Ogni anno dunque in primavera la terra si prepara, gioiosa, all’arrivo della fanciulla, ricoprendosi di fiori, per poi trionfare al suo arrivo in estate, intristirsi in autunno e congelarsi nel dolore in inverno. E’ il modo poetico in cui gli antichi raccontavano l’alternarsi della stagioni. Anche per quest’opera si richiede l’intervento attivo dell’osservatore. Le sculture di Bernini interagiscono con lo spettatore e in questa, in particolare, muovendoci da sinistra, vediamo dapprima il rapimento, frontalmente assistiamo al trionfo di Plutone e solo alla fine ci appare Proserpina con lo sguardo verso il cielo, in una richiesta di aiuto vana, mentre lacrime di dolore le cadono sul viso. Ancora una scena di violenza chiusa in un movimento elicoidale che unisce, in un unicum drammatico, le due figure. Proserpina è viva, e ogni analisi stilistica più o meno intellettuale alla fine deve arrendersi a questo, la vita infusa nella pietra. La mano di Plutone sulla coscia della fanciulla trascende la durezza del marmo per essere altro, diventa carne. La luce rimbalza veloce tra i pieni e vuoti donando un effetto ancor più drammatico, violento e dinamico alla scena. Due donne dal mondo profano e due momenti di terrore catturati e resi per sempre. Luce e ombra raccontano di violenza, di arditi e non corrisposti amori. E’ barocco ed è sublime. Le fortune di Bernini, non a caso l’artista unanimemente acclamato come immenso nella sua e nelle epoche successive, ebbero alterne vicende, strettamente legate alle personali simpatie o antipatie dei papi che si succedettero al soglio di Pietro. Fu osannato da Urbano VIII Barberini ed è proprio in questo momento che vanno collocati due episodi determinanti per la sua vita: la sua nomina ad Architetto della Fabbrica di San Pietro e l’episodio del quale parlò tutta Roma, legato al grande amore della sua vita, Costanza Bonarelli. Nel primo episodio è da vedere la genesi di quella rivalità leggendaria con l’altro grande del tempo, Francesco Borromini che, vicinissimo a Maderno, non perdonò l’affronto di aver posto in ombra l’ormai anziano e amato architetto. Il secondo episodio ci rivela molto dell’animo di Gian Lorenzo. Tanto brillante e diplomatico nella vita pubblica quanto passionale e violento in quella privata. Costanza era la moglie di Matteo Bonarelli, assistente di Bernini assunto nel 1636 per lavorare al monumento di Matilde di Toscana. La passione tra Gian Lorenzo e Costanza è immediata. Di lei, il suo focoso amante non ha lasciato scritti o lettere d’amore ma qualcosa di più, un busto, uno dei pochi ritratti di donna che scolpì e l’unico senza una specifica commissione. L’intimità e la sensualità sono esplicite. Costanza è ritratta al di là del formalismo e della retorica dei ritratti ufficiali, è colta in un momento di quotidianità, una donna vera, colta quasi di sorpresa. Gli abiti e i capelli non hanno ornamenti. La veste leggermente aperta su seno e i capelli appena raccolti sulla nuca sembrano raccontare di una donna che si è appena alzata dal letto. Lo sguardo sembra stupito, e le labbra socchiuse un invito o una parola non detta. Bernini si definì fieramente innamorato e questo ritratto, così lontano dalla sua ritrattistica ufficiale, sembra esserne la prova. Ma la tragedia incombe. Nel maggio del 1638 a Roma corre la notizia di una lite violenta tra Gian Lorenzo e il fratello Luigi. Sembra che Bernini, appostatosi fuori dalla casa di lei, ne abbia visto uscire il fratello in un atteggiamento molto più che amichevole. Furioso Bernini insegue Luigi fino in San Pietro, e là lo ferisce gravemente. Ma fece di più. Costanza la bella doveva pagare per il tradimento. Bernini inviò quindi un suo servo con un rasoio a sfregiare quel viso tanto amato. Solo per la cronaca: del marito di Costanza nessuno parla, neanche un accenno. Luigi pensò bene di allontanarsi da Roma. Solo per intercessione della madre, Gian Lorenzo non fu severamente punito, ma se la cavò con una multa di 3000 scudi. In seguito Urbano VIII convinse Bernini a prender moglie e, il 15 maggio del 1939, lo scultore convolò a nozze con la giovane e bella Caterina Tezio, la ragazza più bella di Roma a quanto si dice, e da lei ebbe 11 figli. Eppure di questa passione, d’amore e di coltello, a lungo si pettegolò nell’Urbe. A noi rimane solo l’incredibile ritratto che l’artista non distrusse mai, il ritratto di una donna amata. Come abbiamo accennato, le fortune di Bernini furono altalenanti. Morto papa Urbano VIII, sale sul soglio pontificio Innocenzo X Pamphili, il quale preferì avvalersi della collaborazione dell’inquieto Borromini e dei Rainaldi piuttosto che di Bernini. Di questo periodo è una delle due opere relative al sacro delle quali mi sono prefissa di parlare; sculture, se possibile, di impatto emotivo ancor maggiore delle precedenti. Nel 1647 lontano dal plauso papale, Bernini viene raggiunto da una commissione privata da una di quelle famiglie presso le quali ancora godeva di stima e ammirazione. Il cardinale Federico Cornaro incaricò Gian Lorenzo di risistemare la cappella di famiglia, nella piccola Chiesa di Santa Maria della Vittoria, e quel che ne venne fuori fu un capolavoro di architettura e scultura senza pari del quale lo stesso scultore si compiacque “il Bernino medesimo era solito dir essere stata la più bell’opera che uscisse dalla sua mano”. Una delle caratteristiche del barocco berniniano è la teatralità, la scelta cioè di trasformare l’esperienza scultorea e architettonica in rappresentazione teatrale. In questo caso ancora di più poichè la cappella stessa viene trasformata in un teatro con spettatori che dai palchi laterali assistono partecipi alla Tranverberazione di Santa Teresa, e i visitatori della cappella, ancora oggi, sono chiamati a osservare ciò che accade tra il pubblico e sulla scena. Bernini scelse di rappresentare un momento preciso seguendo non solo le indicazioni del committente ma le parole stesse della santa. “Un giorno mi apparve un angelo bello oltre ogni misura. Vidi nella sua mano una lunga lancia alla cui estremità sembrava esserci una punta di fuoco. Questa parve colpirmi più volte nel cuore, tanto da penetrare dentro di me. Il dolore era così reale che gemetti più volte ad alta voce, però era tanto dolce che non potevo desiderare di esserne liberata. Nessuna gioia terrena può dare un simile appagamento. Quando l’angelo estrasse la sua lancia, rimasi con un grande amore per Dio”. L’estasi della santa è spirituale e corporeo al punto che molti ne hanno fatto un’analisi psicoanalitica parlando di erotismo sacro. La Santa libra nell’aria con le vesti scomposte mentre un angelo sorridente impugna la lancia dell’amore/dolore. In ogni esperienza mistica che ci sia giunta il binomio corpo/spirito è presente e legato indissolubilmente. È attraverso l’esperienza corporea e la sua trascendenza che si arriva all’unione mistica con il divino. Dalla materia alla spiritualità più intensa e più pura. Il volto di Teresa è levigato e giovane, a ricordo delle testimonianze di chi assistette alla sua morte. Teresa aveva ormai settanta anni, ma al momento della morte parve a tutti un bellissima fanciulla. L’estetica sublime e la drammaticità del volto della donna trasformano ancora una volta il marmo in cera. È un’opera dal virtuosismo tecnico insuperabile che tocca il cuore e rende partecipe chi guarda del miracolo che sta accadendo. Per creare un effetto ancor più dinamico e drammatico, Bernini pose una finestra sopra l’altare e il gruppo scultoreo, in modo che la luce arrivasse a colpire le figure dall’alto e, con i raggi in bronzo dorato, lo spettatore potesse percepire la presenza concreta dell’azione divina. Un capolavoro che ancora oggi lascia senza fiato. Un consiglio? Andate a vederlo, vi lascerà senza fiato. Finito il pontificato di Innocenzo X le fortune di Gian Lorenzo tornarono vigorose con papa Alessandro VII. Da questo momento la carriera di Bernini è trionfale. Gli ultimi anni della sua vita lo trovano anziano ma ancora creativo e vigoroso. È di quest’ultimo periodo l’ultima rappresentazione del sacro femminile di cui vi voglio raccontare. La famiglia Altieri possedeva una piccola cappella nella chiesa di San Francesco a Ripa e decise di dedicare un altare a una terziaria francescana, Ludovica Albertoni, vissuta tra il 1474 e il 1533, la quale era stata beatificata nel 1671, per quelle esperienze di visioni mistiche tanto apprezzate dalla Chiesa del ‘600. La famiglia Altieri, con l’illustre precedente della rappresentazione di Santa Teresa non dubitò per un attimo che l’unico degno di tale commissione fosse Bernini. L’ormai settantenne scultore ancora volta trasformò la pietra in cera. Di nuovo fece della cappella una quinta scenografica, creando due pareti leggermente inclinate e aprendo una finestra sulla parete immediatamente sopra la testa della Beata. Il piccolo spazio sopra l’altare fu trasformato nel letto di Ludovica Albertoni che è colta nel momento culminante dell’estasi mistica. Sono molti i richiami con l’estasi di Santa Teresa. Anche qui il volto della donna è colto nel momento culminante della visione mistica. Corpo e spirito ancora una volta si fondono nel divino, senza negarsi a vicenda, al contrario compenetrandosi e trovando il senso più profondo di Dio nella partecipazione di entrambi alla contemplazione della verità. Il piacere mistico è piacere corporeo sublimato. A noi che oggi ammiriamo questo capolavoro mostra la rappresentazione di quel qualcosa che potremmo chiamare indefinibile, trascendente. Luce e ombra accentuano e forse diventano la metafora del corporeo e dello spirituale. Un capolavoro, le parole non aggiungono nulla a questa semplice verità. Eccoci arrivati alla fine di questo breve racconto. Bernini morì il 28 novembre 1680, ricevendo la benedizione di Papa Innocenzo XI. Morì nella sua casa e fu sepolto in Santa Maria Maggiore dove tutto era cominciato. “C’era così tanta gente intorno alla salma che fu necessario l’indugiare alquanto di tempo a dar sepoltura al corpo”. Cosi’ ci descrive Baldinucci, suo biografo, la calca di persone che si affollarono per rendere l’ultimo saluto all’immenso artista. Sembra uno strano scherzo del destino, ma l’uomo che aveva cantato la bellezza femminile, plasmandola ed eternandola in capolavori che oggi sono tra i più grandi della storia dell’arte, ebbe per sé una sepoltura modesta, una semplice lapide sul gradino… “IOANNES LAURENTIUS BERNINI Decus artium et urbis hic humiliter quiescit (qui riposa Gian Lorenzo Bernini, gloria delle arti e della città) Foto da WEB NEI SOTTERRANEI DI ROMA
LA BASILICA DI SAN CRISOGONO A TRASTEVERE Irene Salvatori Passeggiare per Roma è sempre una scoperta. La storia ad ogni passo ci viene incontro e, tra un resto archeologico e uno scorcio mozzafiato, camminiamo imbambolati e un po’ storditi da tanta bellezza. Roma però non è solo quella che vediamo in superficie. La Città Eterna nel corso nei secoli si è sovrapposta strato su strato. Le nuove epoche hanno coperto, in parte cancellando e in parte inglobando, le testimonianze di tempi più antichi. Ecco perché abbiamo due città: una in superficie e una nascosta, sotterranea. Un po’ ovunque, se si esce dagli itinerari di visita più famosi, si possono ammirare, sotto chiese e palazzi, resti nascosti e a volte sconosciuti. Uno di questi sotterranei poco conosciuti è nel quartiere di Trastevere, sotto la basilica di San Crisogono. Trastevere, ci dicono le fonti, fu uno dei quartieri più popolosi e commerciali di Roma antica. Sorse al di fuori delle mura urbane, e accolse una grande fetta di cittadini stranieri che sempre più arrivavano in cerca di fortuna nella capitale dell’impero. Con essi giunsero, a più riprese, anche i culti e le religioni delle loro terre di origine. Ci dicono che qui abitasse una nutrita comunità di ebrei e cristiani, ma non solo. Un catalogo di epoca costantiniana Il “De notitia et Curiosum” ci fornisce qualche dettaglio in più. Ed ecco che sappiamo che nel trans Tiberim v’erano 4.405 insulae, 16 bagni, 180 fontane pubbliche, 23 forni, 12 granai e la VII coorte dei vigili, che si assicurava che delinquenza e incendi fossero sotto controllo. Sappiamo anche che in questa zona si trovavano tre Titoli cristiani, quello di S. Maria, di S. Cecilia e di S. Crisogono. I Titoli altro non sono che case private messe a disposizione delle neonate comunità di fedeli, nel momento più cupo delle persecuzioni. Le prime riunioni di cristiani avvennero quindi in queste proprietà private, contrassegnate all’esterno da una tabella, un titulus, appunto. Nello specifico di San Crisogono, a più riprese nel corso dei restauri dell’attuale basilica, vennero rinvenute tracce dell’originario luogo di culto. Nel 1878 sotto il pavimento fu visto un capitello e una parte dell’abside. Gli scavi veri e propri iniziarono nel 1908 quando dalle botole di via di San Gallicano cominciarono gli sterramenti. Quello che ne venne fuori andò molto al di là delle aspettative degli scavatori e degli archeologi incaricati del lavoro. Furono portati subito alla luce affreschi del VIII- XI secolo e una serie di ambienti pertinenti non solo all’originale basilica precristiana, ma anche ad altri edifici addossati e poi inglobati nella stessa. Furono rinvenuti pavimenti mosaicati, pitture, sarcofagi, il tutto per un arco cronologico di almeno 7 secoli. Si vide che la basilica che era stata ricavata, verso l’inizio del IV secolo da e tra edifici del II e III secolo d.C., come mostrano interessanti strutture murarie di un edificio poi coperto da affreschi. Oggi la planimetria originale è fortemente alterata dai sostegni e dalle fondazioni della basilica attuale ma si può ben vedere come l’originario luogo di culto avesse un’unica navata terminante con un’ abside e due ambienti con la funzione di battistero e secretarium. Il lato di fondo era chiuso dalla facciata di una domus o insula che ancora si conserva. L’ambiente del battistero in origine deve essere stato una fullonica, una lavanderia come tante ce n’erano nella zona. Aggirarsi oggi nei sotterranei è come prendere un ascensore del tempo che ci porta indietro in una Roma viva e brillante di 2000 anni fa. La luce soffusa e un po’ retrò illumina le varie stanze e edifici inglobati nel tempo nella chiesa, e ci riempie gli occhi con incredibili affreschi, ancora oggi in situ, raffiguranti le storie di San Benedetto. Per un certo periodo la basilica ebbe anche funzioni cimiteriali, come quasi tutte le basiliche dell’epoca. Numerosi sono i ritrovamenti di sarcofagi in marmo o in terracotta e di lastre tombali che coprivano le sepolture a fossa del pavimento. Fu il Cardinale Giovanni da Crema che nel XII secolo fece interrare la vecchia basilica e ordinò la costruzione della nuova a sei metri più in alto dal piano di calpestio originario. La nuova chiesa non sorse esattamente sulla precedente, ma un po’ spostata verso destra. In quell’occasione venne anche alzato il campanile romanico, che oggi si può vedere, e vennero aggiunte altre due navate. L’aspetto attuale della chiesa si deve però al Cardinale Scipione Borghese che, tra il 1620-26, procedette al restauro barocco della facciata e di parte dell’interno. Oggi chi entra viene acconto dallo splendore dei pavimenti cosmateschi e da tavole che portano nomi da far girar la testa: Pietro Cavalli, al quale sono da attribuire alcuni dipinti del catino absidale, oggi purtroppo scomparsi, ma rimane ancora una tavola al centro del tamburo. Il Cavalier D’Arpino, Guidotti, Bracci e Bernini che disegnò la Cappella del Sacramento. Un tesoro la basilica di San Crisogono… fossi in voi una visitina ce la farei. La congiura di Caligola
Il percorso, i luoghi… e qualche dubbio Irene Salvatori E’ il 24 gennaio. Caligola ha appena fatto un sacrificio al Nume di Augusto, presso il vestibolo della casa del suo nobile avo (1), nonché primo Imperatore. È una mattina fredda ma il cielo è cristallino. Un giorno sacro. Un giorno di festa. Quel giorno si celebravano i Ludi Palatini, presso il tempio della Magna Mater. Caligola presiede ai giochi ma all’ora di pranzo decide di fare una pausa e tornare nella dimora imperiale. Con lui s’incamminano Claudio e il suo seguito. Dalle fonti sembra che il piccolo gruppo preceda l’Imperatore. Entrati nel palazzo, Claudio e il seguito percorsero la strada più diretta, mentre Caligola piegò verso una scorciatoia angusta, solo, senza la scorta dei fedeli Germani. Sembra che l’Imperatore si sia attardato ad ascoltare un gruppo di fanciulli, di alta nobiltà greca, che stavano facendo delle prove per l’esibizione del pomeriggio. Là Caligola fu raggiunto da alcuni uomini, tra questi Cherea e Sabino, che circondarono e uccisero l’Imperatore. Il corpo fu poi portato nella Domus Gaii e là, davanti ad esso, furono trucidate anche la moglie e la figlia dell’Imperatore, con ferocia inaudita. I congiurati fuggirono dal Clivio della Vittoria e da là si dispersero. Oggi visitando il Palatino si possono vedere o almeno ricostruire idealmente i due percorsi di Claudio e Caligola. Recenti scavi hanno portato alla luce, sotto gli Horti Farnesiani, alcuni ambienti, che sembrano essere appartenuti a quell’area in cui fu trucidato Caligola. Molto suggestiva è anche la veduta del Clivio della Vittoria. Del dramma e della violenza oggi non resta più nulla. Quel che rimane è la suggestione di angoli stupendi e una veduta da mozzare il fiato. In particolare nel Clivo della Vittoria sembra di tornare indietro di 2000 anni. Eppure la Storia, con la maiuscola, ad ogni passo ci viene incontro. Caligola è uno dei personaggi maledetti della storia di Roma, appartenuto all’altrettanto dannata dinastia giulio-claudia. Senza voler difendere nessuno a tutti i costi, vorrei dire però che leggendo le fonti, ogni qual volta che un personaggio si è posto come contraddittorio dello status quo vigente è stato bollato come malfattore, pazzo e sovversivo. Da Catilina in poi, passando per i giulio-claudi ad arrivare a Domiziano e Commodo, le fonti, parlando di queste figure controverse e condannate alla damnatio memoriae, sembra usino sempre uno schema ben preciso, a volte contraddicendosi anche all’interno dello stesso testo. Perché? La storia la scrive chi vince e certo per un periodo così lontano non è facile recuperare una realtà oggettiva dei fatti. Ma oggi gli storici hanno la volontà di approfondire, di leggere tra le righe e di analizzare non solo i personaggi così come ci sono stati tramandati, ma inserendoli in un più vasto programma di ricerca socio-economico. Per cui Tiberio non è più il vecchio lascivo che da Capri si diletta in festini e bagordi, ma un grande generale e un amante delle lettere, con una pesante eredità: l’Impero. Forse non avrebbe voluto essere imperatore e certo il suo limite fu di non aver trovato il modo di comunicare con le masse. Caligola il pazzo. O forse, da Caligola comincia a cadere la falsa ipocrisia dell’Imperatore ossequiente. Se Augusto, un grande baro, aveva tenuto aperto, anche solo apparentemente, un dialogo con il Senato, anche solo a livello formale e non di sostanza, con Caligola tutto ciò viene interrotto, e il giovane Imperatore, non accettando più le regole del gioco, metterà i maggiorenti di fronte alla loro stessa ipocrisia e contraddittorietà. Claudio. Leggendo le lettere di Augusto a Livia, dovremmo immaginarlo come uno stolto balbuziente e zoppo, imbarazzante quasi e molto lontano dal machismo romano. Forse, ma al momento della sua inaspettata ascesa al trono i Romani si trovarono di fronte a uno degli uomini più colti dell’Impero. Nerone, oh Nerone! Oggi si sta finalmente sdoganando lo stereotipo del Nerone incendiario e sanguinario. Una politica attenta e vicina al sociale piuttosto. Il fatto è che chi scrisse apparteneva a quella classe senatoria tanto osteggiata dagli imperatori, oppure riportava fatti accaduti 100 anni prima. La verifica della verità vera di un evento è difficile anche per anni a noi più vicini per cui, rimandando ad una trattazione più ampia, quello che per ora propongo è il legittimo dubbio. Troppo, tutto e tutto insieme: questo è il leit motiv con cui si procede alla dannazione di un personaggio. Affidabili o meno, le fonti storiche sono però sempre incredibilmente affascinanti da leggere, ci riportano a un tempo lontano, del quale oggi possiamo ammirare, stupiti, ammirati e increduli, i resti. La morte di Caligola, Svetonio, 58,59 “Il nono giorno prima delle calende di febbraio, verso l’ora settima, era incerto se recarsi a pranzo, sentendosi lo stomaco ancora appesantito per quando aveva mangiato il giorno precedente; alla fine si alzò, ma solo in seguito alle pressioni dei suoi amici. In una galleria che doveva attraversare, alcuni ragazzi di nobile famiglia, che aveva fatto venire dall’Asia perchè si esibissero sulla scena, stavano facendo le prove per lo spettacolo; si fermò un momento a guardarli, e, se il loro capo non lo avesse avvertito che avevano freddo, avrebbe voluto tornare indietro e far rappresentare lo spettacolo. Da questo momento vi sono due versioni diverse: alcuni dicono che, mentre stava parlando coi ragazzi, Cherea lo ferì gravemente alla nuca, con un colpo di taglio della spada, esclamando “colpisci!”, e che quindi il tribuno Cornelio Sabino, l’altro congiurato, lo trafisse al petto. Secondo altri, invece, Sabino, dopo aver fatto allontanare la folla da alcuni centurioni al corrente della congiura, gli aveva chiesto, secondo l’uso militare, la parola d’ordine, e quando Gaio aveva risposto ”Giove!”, Cherea gridando “eccolo!” gli aveva fracassato la mascella mentre si voltava. Caduto a terra con le membra contratte continuava a gridare “sono vivo”, gli altri lo ferirono con trenta ferite...visse 29 anni e fu imperatore per tre anni, dieci mesi e otto giorni. Il suo cadavere, trasportato di nascosto nei giardini di Lamia, fu posto sopra un rogo improvvisato e poi sepolto, semi combusto, sotto un leggero strato di zolle erbose. Le sorelle, quando tornarono dall’esilio, lo disseppellirono, lo cremarono e gli resero onoranze funebri... Assieme a lui fu uccisa sua moglie Cesonia, trafitta dalla spada di un centurione, e sua figlia, sfracellata contro una parete.” (1) Il bis nonno in realtà. Caligola è figlio di Germanico e Agrippina Maggiore, a sua volta figlia di Giulia, figlia di Augusto. L'imperatore ripudìò Giulia ma reintegrò i nipoti per i quali, giuridicamente, fu un "prozio", anche se nonno a livello parentelare. |
Archivi
March 2023
,Tutti i diritti riservati. Si prega nel caso si volesse usare il testo o una parte di esso di citare la fonte.
IRENE SALVATORI |
Proudly powered by Weebly



















































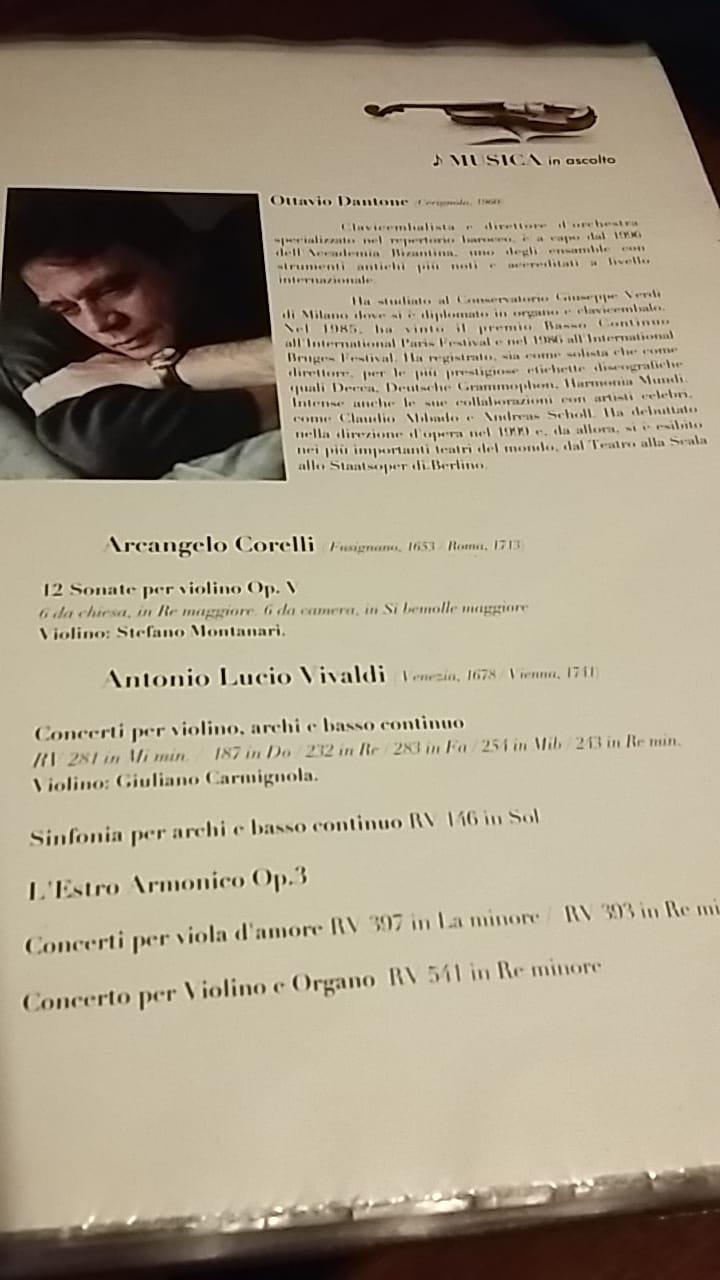


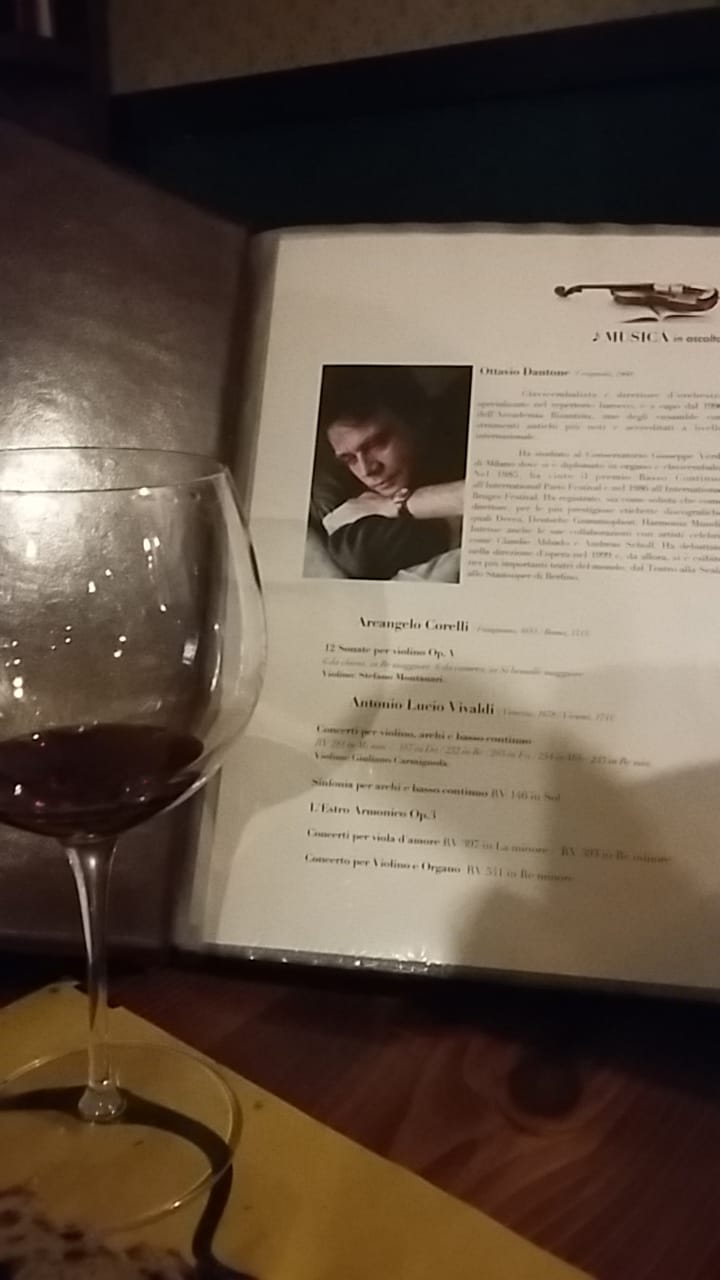


































 RSS Feed
RSS Feed